L’«inganno» di Alan Sokal
Apparently,
the original article in French may be found
here.
I pensatori «postmoderni» mancano di rigore
e di cultura scientifica? Per saperlo,
un fisico americano ha fatto un esperimento
di Pierre Thuillier or from Thuillier here?  or, securely without constant renaming, from my archive.
or, securely without constant renaming, from my archive.
LE SCIENZE n. 349, settembre 1997
"La pigrizia e l’impostura
intellettuale vanno denunciate
ovunque si trovino."
Questa è la giustificazione fornita dal fisico
Alan Sokal, dell'Università di New
York, dopo essersi permesso un
brillante scherzo che ha fatto versare fiumi di
inchiostro. Ricordiamo i fatti.
Nel maggio 1996, la rivista americana «Social Text» pubblica un articolo
di Sokal dal titolo reboante: Violare le
frontiere: verso un’ermeneutica trasformatrice della gravità quantistica.
Uno degli obiettivi apparenti di quell’articolo è quello di rimettere in
discussione i fondamenti della scienza ortodossa.
Il razionalismo occidentale è riuscito
a imporre un «dogma»: esiste un mondo
esterno di cui è possibile scoprire progressivamente le leggi. Ora, afferma
Sokal, diversi studi revisionisti, feniministi e post-strutturalisti
hanno ridotto a
mal partito quella fiducia, mostrando
che la realtà fisica è essenzialmente
«una costruzione sociale e linguistica».
La scienza moderna, dunque, ha solo
una «facciata d’oggettività» e i privilegi
epistemologici accordati al «preteso metodo scientifico» non
sono meritati.
Stando all’articolo, si
dovrebbe smettere di venerare il «concetto di
verità» e, anzi, sbarazzarsene. Si potrebbe così
dar vita a una nuova
scienza, finalmente «postmoderna» e
«liberatrice». Non solo si farebbero saltare le barriere
che separano ancora gli
scienziati dal grande
pubblico, ma «si depurerebbe l’insegnamento
delle scienze e della matematica dalle loro caratteristiche
autoritarie ed elitarie».
Vi si introdurrebbero, in compenso,
idee mutuate dai sostenitori del femminismo, dell’omosessualità, del
multiculturalismo e dell’ecologismo. Sokal animette che sarebbe difficile
immaginare l’aspetto del nuovo «albero della scienza»,
ma nella sua conclusione azzarda comunque la previsione seguente: la teoria
del caos, in quanto capace di gettare luce
«sul misterioso fenomeno della non linearità, occuperebbe una posizione
centrale in tutta la matematica futura».
Per sostenere le sue affermazioni
Sokal, da una parte, rimanda alla gravità quantistica, «questa nuova branca
della fisica in cui si trovano contemporaneamente sintetizzate e superate la
meccanica quantistica di Heisenberg e
la relatività generale di Einstein»; dall’altra, cita una moltitudine di
intellettuali che praticano la filosofia,
la sociologia della scienza o i cultural studies
(una riflessione di tipo umanistico sui
grandi problemi socioculturali). Adottando il loro linguaggio, Sokal procede
a una vasta «decostruzione» del pensiero scientifico, rimettendo radicalmente
in dubbio le conoscenze più consolidate. Non senza abilità letteraria, scrive
per esempio: «Così il gruppo d’invarianza infinito-dimensionale erode la
distinzione tra osservatore e osservato;
il π di Euclide e il g di Newton, un
tempo considerati costanti e universali,
sono ora visti nella loro ineluttabile storicità». O ancora, imperturbabile,
propone questo criterio «epistemologico»:
«Le grandezze o gli oggetti che sono in
linea di principio inosservabili - come i
punti dello spazio-tempo, le posizioni
esatte delle particelle o i quark e i gluoni - non dovrebbero essere introdotti
nella teoria». Di passaggio, segnala uno
degli inconvenienti di questa innovazione: essa esclude dalla scienza «gran
parte della fisica moderna» ...
UNA PREVARICAZIONE A FIN DI BENE?
In questo modo comincia l’affaire.
Perché, quasi nello stesso momento,
Sokal pubblica su un’altra rivista americana, «Lingua Franca», un secondo
articolo in cui rivela di aver inscenato
una parodia, un affastellamento deliberato di enunciati
approssimativi, fantasiosi, falsi o addirittura assurdi.
Precisando che le citazioni di autori postmoderni erano
rigorosamente esatte, il nostro buontempone confessa
di avere imbastito una pseudodimostrazione del tutto inconsistente.
In realtà, si trattava di un esperimento: «Una
rivista di punta consacrata ai Cultural Studies
pubblicherebbe un articolo infarcito di assurdità:
a) se avesse un certo stile,
b) se fosse compiacente verso i presupposti ideologici della redazione?
La risposta, purtroppo, è sì». Di conseguenza, non
si può che deplorare «l’arroganza intelettuale» e la mancanza di rigore dei
teorici della rivista.
Sokal si chiede in particolare perché la
redazione non abbia ritenuto utile consultare un fisico,
cosa che avrebbe consentito di evitare banali trappole. Per
esempio, la teoria dei numeri complessi
era presentata come «una branca recente
e ancora del tutto congetturale della fisica matematica»
(i numeri complessi vennero introdotti nel Rinascimento e Gauss
diede a essi l’attuale statuto matematico
negli anni trenta del secolo scorso).
O ancora, Sokal aveva parlato della «vittoria» della cibernetica
sulla meccanica quantistica... Una vittoria, evidentemente,
del tutto immaginaria. La cibernetica
è una disciplina specifica che non ha in
alcun modo l’obiettivo di soppiantare la
meccanica quantistica. Al massimo, il
grande pubblico può considerarla più
prestigiosa. Un comitato di redazione attento non avrebbe mai lasciato passare
affermazioni così bizzarre; e, anche senza l’aiuto di esperti,
si sarebbe reso conto
dell’estrema debolezza di certe argomentazioni. Come credere, per esempio, che
gli ultimi sviluppi della meccanica quantistica abbiano confermato
le teorie psicoanalitiche di Jacques Lacan?
Sokal riconosce che il suo
esperimento solleva una questione etica. La comunicazione tra intellettuali
avviene sulla base della fiducia
e, in questo caso, vi è stato un
inganno deliberato. In definitiva, egli si affida a una giustificazione
di tipo politico. Sostenendo di appartenere
anch’egli alla «sinistra», lamenta che una certa sinistra
americana tradisca gli ideali
progressisti legandosi a quello che egli definisce
«relativismo epistemico»; in altri
termini, che rinunci a distinguere il falso dal vero e getti il
discredito sulla scienza. Non
è ricadendo nell’oscurantismo, dichiara Sokal, che si
lotterà contro l’AIDS o contro il riscaldamento del clima.
È come condurre una riflessione critica in economia o in
politica se si abbandona il lume dell’intelletto?
«Social Text» ha avuto i suoi problemi a difendersi.
Sui mezzi di informazione, dal «New York Times» a
«Physics Today», si sono moltiplicati gli articoli che si
ponevano la domanda: Sokal aveva fatto bene a mettere in piedi una
simile mistificazione? Anche in Francia il caso ha suscitato vivaci polemiche. In
«Le Monde» del 3 gennaio 1997, il sociologo Denis Duclos ha rimproverato al
fisico americano e ai suoi accoliti di essere «pistoleri della correttezza
intellettuale» e di indulgere ad «autodafé simbolici»,
nello stesso tempo cinici e stupidi, deplorandone in particolare lo
«sciovinismo antieuropeo».
Su questo punto specifico, però, è difficile essere d’accordo.
È vero che molti
europei, e in particolare molti francesi, sono presi di mira, ma è altrettanto
vero che sono messi in causa anche numerosi autori americani. Gli europei non sono
criticati per la loro nazionalità, ma perché hanno utilizzato in modo maldestro,
erroneo o arbitrario enunciati scientifici male assimilati, e perché hanno
esercitato una grande influenza sulla «nuova sinistra» americana.
Il vero bersaglio è il
postmodernismo, vale a dire una corrente di pensiero che, secondo Sokal, manca
totalmente di rigore intellettuale.
Gli esperti di scienze umane hanno certamente il diritto di fare
riferimenti alle scienze «dure», ma a patto di evitare
impostare. Se uno psicologo o un linguista pretende di condurre argomentazioni
«serie» sulla base della topologia, allora deve informarsi in modo
altrettanto «serio» su questa branca della matematica.
D’altra parte, per sostenere la sua critica, Sokal ha trovato un alleato europeo
in Jean Bricmont, professore di fisica teorica all’Università cattolica di
Lovanio. Insieme stanno per pubblicare un libro che dovrebbe intitolarsi:
Le imposture scientifiche dei filosofi (post)moderni.
La loro intenzione è quella di analizzare
minuziosamente diversi testi postmoderni al fine di mettere in luce i
«recuperi» e i «travisamenti» del teorema di Gödel,
della dinamica dei fluidi, delle relazioni
di Heisenberg e di diverse altre teorie.
RELATIVISMO MODERATO
E RELATIVISMO RADICALE
Per importante che sia, questa è solo
un’operazione iniziale di sgombero del
terreno. Il problema principale, secondo
lo stesso Sokal, riguarda il relativismo
ostentato dai postmoderni. Ricordiamo
che, nella sua forma estrema, questa dottrina afferma che tutte le conoscenze si
equivalgono: la scienza, nonostante le
sue pretese, è solo una tra le tante forme
di conoscenza e non si colloca quindi al
di sopra della magia, dell’astrologia o
della religione. In altri termini, le «teorie
scientifiche» non sono altro che costruzioni elaborate a partire da qualche
presupposto arbitrario e in funzione di interessi economici, sociali, politici
o culturali. Alcuni «sociologi della scienza»
non esitano a dirlo in termini brutali: le
scienze non esistono. Non ci sono teorie,
ma solo rapporti di forza. Almeno in certi ambienti intellettuali, affermazioni di
questo tipo conoscono una grande popolarità.
È necessario capire bene qual è il
risultato di questa posizione:
il concetto stesso di scienza è
svuotato di contenuto.
È appena il caso di dire
che questa «sociologia» ha
sollevato innumerevoli discussioni. È ragionevole, per
esempio, svuotare di significato tutta l’attività sperimentale dei
fisici e dei biologi, e sostenere che il «vero» e il
«falso» si manifestano allo
stesso modo (vale a dire sociologicamente)? Se ne può
dubitare, come fa Sokal. Il suo giudizio, d’altra parte,
non è così netto come si potrebbe credere di primo
accinto. Per cogliere correttamente il suo pensiero, è utile
distinguere, all’interno del
relativismo, le forme moderate da quelle radicali.
In effetti, ben prima che la nuova «sociologia della
scienza» diventasse di moda, numerosi filosofi e storici della scienza avevano
osservato come il funzionamento del «metodo sperimentale» sia molto più
complesso e molto meno trasparente di
quanto sostenuto da una certa tradizione. Molti uomini di scienza hanno essi
stessi spiegato, a volte con spirito, che
la pura razionalità non basta per spiegare il successo delle teorie. Max Planck,
premio Nobel per la fisica nel 1918,
scriveva nella sua Autobiografia:
«Nelle scienze, una verità nuova non arriva
mai a trionfare convincendo gli avversari e portandoli a vedere la luce, ma
piuttosto perché alla fine quegli avversari muoiono e matura una nuova
generazione a cui quella verità è familiare».
Anche nelle scienze ci sono mode,
pressioni sociali, travisamenti vari dovuti
a cause altrettanto varie: una pubblicazione
precipitosa di risultati scarsamente
confermati, la «dimenticanza» più o meno voluta di certi fatti scomodi, piccoli o
grandi imbrogli eccetera. Inoltre è diventato piùo meno chiaro che ogni
teorizzazione mette in campo scelte e presupposti suscettibili di essere
contestati e modificati. È quello che si potrebbe chiamare
relativismo moderato: mette in evidenza
i limiti della «scienza» ma si guarda bene dal negare radicalmente la sua
speciflcità e la sua efficacia cognitiva.
Pur mantenendo una certa distanza, Sokal fa larghe concessioni a questa
forma di relativismo. In un testo posteriore alla sua parodia, per esempio, ha
dichiarato che sarebbe ingiusto criticare
indistintamente tutti i relativisti. Alcuni di loro hanno abbastanza buon senso
per riconoscere che certi enunciati empirici hanno valore oggettivo, e
formulano nei confronti di molte teorie critiche degne di essere prese
in considerazione. Sokal ammette ugualmente che
lo scetticismo, a condizione d’essere «informato», ha una funzione positiva.
Ciò che rifiuta è il relativismo radicale.
Nel contempo poco rigorosi e ipercritici, i sostenitori di questa dottrina
finiscono per svalutare non solo la scienza,
ma anche le norme elementari del lavoro intellettuale (rigore, coerenza,
verifica delle informazioni eccetera).
Torniamo così al progetto iniziale di Sokal: stabilire «sperimentalmente» che
un intero settore della sinistra americana
si è smarrito nel postmodernismo. Pur
non avendo propriamente dimostrato la
pericolosità politica di questa deriva, si
direbbe che sia quanto meno riuscito a
svelare le debolezze e anche la vacuità di
un certo tipo di produzioni intellettuali.
Si può sperare che, sulle due sponde dell’Atlantico,
le divagazioni pseudoscientifiche dei postnioderni si facciano sempre
più rare. Rimangono tuttavia aperte alcune importanti questioni:
sarebbe spiacevole se certe affermazioni di Sokal le facessero dimenticare.
A diverse riprese, per esempio, egli
ha affermato che non si dovevano mischiare le questioni epistemologiche con
quelle etiche, le questioni di fatto con
quelle relative ai valori. L’idea è certamente giusta, almeno se vuole dire che
non si deve condannare una teoria scientifica con il pretesto che
è stata utilizzata
dall’esercito o dalle imprese capitalistiche ...
Sokal non nega peraltro la necessità di interrogarsi sul funzionamento
sociale della scienza. Nel corso della
controversia con «Social Text» ha affermato con estrema chiarezza:
«La scienza e la tecnologia sollevano centinaia di
importanti questioni politiche ed economiche. D’altra parte, la sociologia della
scienza, nella sua forma migliore, ha contribuito grandemente a chiarirle».
I presupposti filosofici sui quali poggiano
le diverse discipline possono, evidentemente, costituire oggetto di discussione.
In breve, la denuncia dei trucchi intellettuali non implica in alcun modo un
annullamento dello spirito critico in politica e in filosofia,
fosse anche solo a proposito di scienza.
In linea di principio, non avrebbero
dovuto esserci malintesi; in concreto, invece, lo scompiglio provocato
dall’affaire non ha sempre favorito il dialogo e la
lucidità. Bisogna animetterlo: l’«esperimento» di Sokal si rivela
pedagogicamente efficace, ma è brutale e rischia di
provocare un irrigidimento. Come mostrano le reazioni di alcuni rappresentanti
delle scienze sociali, è stato sentito a volte come un’aggressione e addirittura
un umiliazione. Si spiega in questo modo il riflesso di difesa di Duclos: «Non è
certo perché una rivista di scienze sociali
cade nella trappola di alcuni errori di fisica che le questioni sociali cessano di
avere una loro radicale autonomia».
Più in generale, l’inganno di Sokal ha
potuto far temere il ritorno di un certo
«terrorismo» scientista: la scienza, sola
detentrice del vero, dovrebbe essere considerata da tutti e in tutti i campi come
l’autorità suprema... Un tale progetto, diciamolo con fermezza, non corrisponde
certamente alle intenzioni di Sokal. Egli
non chiede un’idolatria della scienza; si
augura solo che i postmoderni rinuncino
al loro lassismo intellettuale.
PIERRE THUILLIER, filosofo e storico della scienza,
per molti anni redattore della rivista «La Recherche», insegna
attualmente all’Università di Parigi VII.
THUILLIER PIERRE, La revanche des
sorcières. L ‘irrationel et la pensée
scientzfique, Èditions Belin, 1997.
Ulteriori informazioni sull’affaire Sokal si possono reperire sul sito Web:
http://www.physics.nyu.edu/facuity/sokal/index.html

Last updated : June 25, 2003 - 20:47 CET
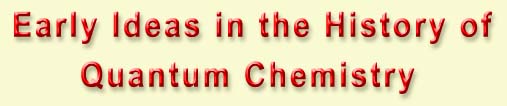
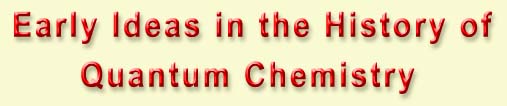

 or, securely without constant renaming, from my archive.
or, securely without constant renaming, from my archive.
